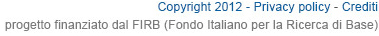Il funerale
 |
 |
A differenza del matrimonio, in Italia il funerale civile è discriminato. Sebbene esista infatti una legge che dice che in ogni Comune deve esserci una "Sala del Commiato" per i riti funebri laici, molti Comuni non ne sono ancora provvisti. In generale, non ci sono pari possibilità per chi non vuole un funerale religioso rispetto a chi fa il funerale religioso (cattolico o non). In effetti, sembra che in Italia il funerale cattolico sia il rito "normale", per cui molto spesso capita di vedere funerali cattolici per persone che in vita erano non credenti o che non hanno mai frequentato la chiesa, come se fare il funerale in chiesa fosse qualcosa di automatico e scontato, spesso senza considerare quali fossero le convinzioni del morto. Questa è probabilmente la conseguenza della forte influenza della cultura cattolica in Italia, che ancora oggi (anche se meno di un tempo) spesso si impone come cultura, appunto, "normale", nel senso che molte persone si sposano in chiesa, fanno funerali in chiesa, prendono sacramenti cattolici semplicemente perché "si usa così". Anche in Italia, tuttavia, ci sono stati funerali laici famosi, come per esempio quello di Palmiro Togliatti nel 1964, al quale parteciparono oltre un milione di persone e che è stato immortalato in un famoso quadro di Renato Guttuso.

In Italia ci sono alcune manifestazioni di lutto legate a quando muore una persona importante oppure a quando avvengono morti che toccano particolarmente l'opinione pubblica. Per esempio, c'è l'usanza di mettere le bandiere a mezz'asta o tenere le saracinesche dei negozi abbassati. In caso di funerali di stato, la bara viene anche coperta dalla bandiera tricolore. Questi sono segni di rispetto che si usa esporre nel caso di lutto cittadino o nazionale, cioè quando le autorità proclamano il lutto, appunto, di tutta la città o di tutta la nazione.
 Bandiera italiana a mezz'asta all'Altare della Patria a Roma |
 Funerale di Stato per il magistrato anti-mafia Giovanni Falcone nel 1992 a Palermo |
 Saracinesche abbassate in segno di lutto a Firenze per l’omicidio di due ragazzi senegalesi da parte di un fanatico razzista (13 dicembre 2011) |
Sempre nel caso di morte di persone importanti, può essere presente una banda musicale che accompagna il trasporto della bara.
Molto spesso, immediatamente dopo la morte di una persona della famiglia, i parenti fanno esporre nella città o nel quartiere un "manifesto funebre", cioè un manifesto in cui si annuncia appunto la morte della persona interessata. Solitamente, nel manifesto sono indicati ora e luogo del funerale e spesso si trova la frase "non fiori ma opere di bene" oppure "non fiori ma offerte per...": questo significa che il defunto o i suoi parenti preferiscono che coloro che parteciperanno al funerale non spendano soldi in fiori, ma piuttosto li diano in beneficienza. Talvolta c'è anche la foto della persona morta.

Manifesto funebre con la frase "non fiori ma offerte pro A.N.T." (A.N.T. = Associazione Nazionale Tumori)
Dopo l'eventuale funerale, in Italia il morto può essere seppellito oppure cremato e dal 2001 le ceneri possono essere conservate oppure sparse in spazi aperti (mare, montagna). Fino al 1963 la chiesa cattolica vietava la cremazione del corpo, mentre ora la permette, purché le ceneri siano comunque sepolte e non siano disperse né tenute in casa.
In occasione della morte di una persona conosciuta, in Italia si usa mandare un telegramma alla famiglia, nel quale si esprimono le proprie condoglianze. Mandare il telegramma è un gesto gentile e abbastanza formale, che significa "ti dimostro che sto pensando a te a che mi dispiace per quello che è successo, ma non voglio essere invadente perché in questo momento probabilmente vuoi avere vicino solo le persone più care". Se invece i rapporti con la famiglia del morto sono di maggiore confidenza, di solito si comunica per telefono o direttamente di persona.
Un'usanza abbastanza singolare che, soprattutto nell'Italia meridionale è sopravvissuta fino a non molti anni fa, era quella di assumere donne che piangevano a pagamento durante i funerali, le prefiche. Avere molte persone che piangono al funerale era considerato segno di onore e rispetto per il morto. La prefica esisteva del resto già nell'antica Roma e nell'antica Grecia. Nel corteo funebre stava con i capelli sciolti in segno di lutto e cantava lamenti funebri, a volte graffiandosi la faccia e strappandosi ciocche di capelli.